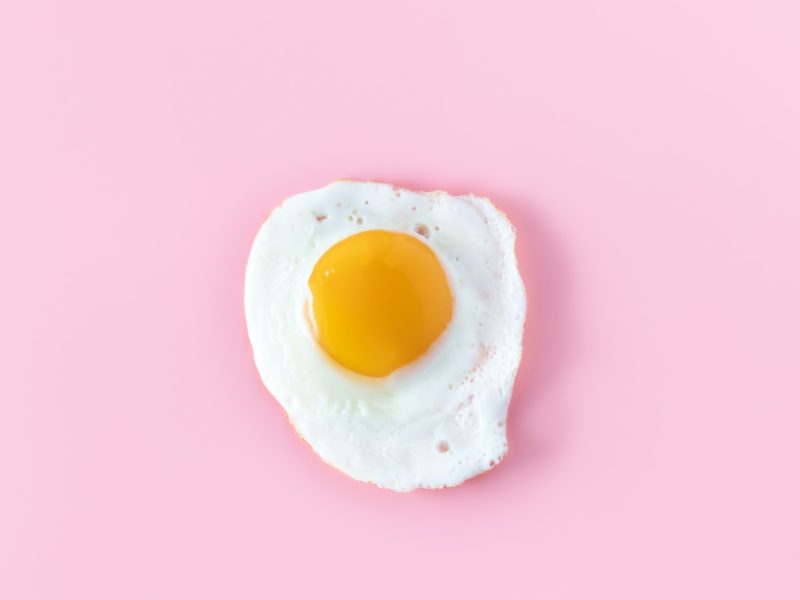Relazione di attaccamento nei DCA
Alla nascita in ogni essere umano esiste una coincidenza tra gli stati emotivi di piacere e dispiacere e le proprie percezioni corporee; questo prerequisito permette all’individuo di raggiungere l’immagine corporea ed elaborare un senso di identità.
L’identità corporea è fondamentale sia per il bambino che per la madre in gravidanza, quest’ultima dovrà adattarsi alle proprie trasformazioni corporee per poter trasmettere al figlio una confidenza e una cura verso il proprio corpo.
Un adattamento patologico della madre finirà per minare il rapporto corporeo con il figlio. Alla nascita il bambino avverte confusamente i diversi bisogni fisiologici; è attraverso la risposta corretta ai suoi segnali che apprende a differenziare e percepire chiaramente strutturando la percezione del proprio corpo e la costruzione dell’immagine corporea.
Nel caso in cui la somministrazione di stimoli è disturbata, la percezione corporea del bambino è distorta, e influenzerà negativamente la costruzione dell’Io corporeo e di quello mentale.
Questa antica esperienza si riscontra nella lenta strutturazione di una patologia alimentare. Un rapporto disturbato della madre con il corpo della figlia in grembo può derivare da un contatto della madre con il proprio materno interiorizzato.
Durante la gravidanza si attiva la relazione della madre con il proprio corpo e la propria femminilità; la nascita della bambina riattiva in tutta la sua intensità il rapporto problematico, quando c’è, che la madre ha con il corpo femminile.

Una condizione che danneggia il rapporto con il figlio in grembo sono le fantasie patologiche o assenti che possono svelarsi nella madre in gravidanza. Sintonizzata sulle proprie paure, essa non riesce, attraverso la sua funzione di réverie (Bion, 1962a), a sintonizzarsi sui bisogni del figlio.
In queste situazioni, condizionata ad ottenere rassicurazione alle proprie paure, la madre fornirà risposte monotematiche modellate da queste potenti angosce.
Se la madre teme inconsciamente che il piccolo possa morire, risponderà al pianto angosciato nutrendolo, in questo modo sentirà di essere una buona madre e allontanerà la paura della morte, oppure angosciata per non comprendere i segnali di sofferenza del bambino, dopo tentativi confusionari cercherà di placarne il pianto con la somministrazione alimentare.
Il rifiuto del nutrimento percepito come avvelenato dal bambino o il rigurgito scaturirà nella madre il pensiero che il figlio sia malato o che le voglia fare un dispetto.
Queste risposte sono frequenti nella storia delle patologie alimentari portate da pazienti adulte; infatti, le madri delle future anoressiche o bulimiche rispondono in termini alimentari ad ogni disagio del figlio perché possedute dalle loro angosce di morte.
Questa risposta monotematica genera confusione nel linguaggio corporeo del figlio fornendo le basi per lo sviluppo di patologie che riguardano lo psicosoma.
È in questa fase che inizia la distorsione corporea tipica dei DCA (psicosomatici).Il rapporto con il cibo è di fondamentale importanza per il bambino che attraverso il nutrimento fa esperienza del mondo.
Dalla figura materna impara il senso del piacere: il cibo buono oltre a soddisfare l’appetito e il gusto gli rinforza l’immagine della mamma buona, requisito essenziale per esercitare l’affettività, le emozioni e, più tardi, a viversi una buona sessualità.
Fonte: Montecchi, F. (2012). I disturbi alimentari nell’infanzia e nell’adolescenza.